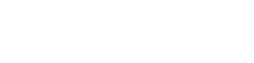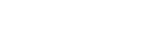Maurilio Barozzi
Jorge Ben canta l’India del Taj Mahal - Maurilio Barozzi
mercoledì 5 giugno 2013
MUMBAY – Ho trovato un filo rosso che lega l'India al mio adorato Brasile. Un filo che va oltre il fatto che entrambi siano considerati 'Paesi emergenti', dove però povertà e emarginazione dilagano. Che va oltre il fatto che entrambi siano Paesi maschilisti ma dove una delle persone più potenti è una donna – Sonia Gandhi – in India; mentre è donna la prima ministra – Dilma Rousseff – in Brasile. Un filo che va oltre le distanze siderali che si frappongono tra città e città, anche se sarebbe più preciso chiamarle megalopoli. Che va oltre una spiritualità esibita a proprio modo in entrambi i Paesi ad ogni occasione.
Il filo rosso che mi ha guidato in India è una canzone brasiliana che rievoca il suo monumento icona e che – nella sua versione granagliata e probabilmente banalizzata – tutto il mondo conosce per il capodanno. Tale canzone, nella sua semplicità che trasmette allegria contagiosa, parla di un principe e una principessa innamorati e parla del palazzo bianchissimo di Agra che le dà il titolo, Taj Mahal. E parla di bellezza. L'ha scritta Jorge Ben Jor in Brasile, l'ha cantata mezzo mondo, nasce da una vicenda indiana del 1600 e rotti.
È una storia di amore, di disperazione, di ricordo, di avversità, di consolazione e infine di beata rassegnazione. Il protagonista è un imperatore, il Gran Mogol Shah Jahan, innamorato della moglie al punto da ingrigire in un sol giorno quando lei, la ‘princesa’ Mumtaz Mahal, morì partorendo. In sua memoria tra il 1632 e il 1653 fece costruire il Taj Mahal che così divenne il mausoleo del loro amore durato da quando lei era diciannovenne. Travolgente, per quelle latitudini e per quella cultura. Lei lo seguì devotamente ovunque andasse, anche in battaglia. Lui la ricambiò facendone la favorita del suo harem.
Quel palazzo spandeva affetto. Bianco, con l’alba che lo tinge di rosa illuminando di gentilezza le quattro torri e la cupola: qualcuno dice sia tuttora il più bell'edificio del mondo. Ma fu proprio appena terminato che il perfido figlio imprigionò il Mogol per prenderne il posto. E lo rinchiuse a Fort Agra, da dove Shah poteva solo vedere da lontano il simulacro della sua vita con Mumatz. Il Taj Mahal fa versare lacrime dagli occhi del sole e della luna, diceva struggendosi. Non si pacificò fino al 1666, quando morì e fu finalmente ricongiunto alla sua amata, nel sepolcro.
Sì, d'accordo, per raccontare un viaggio in India avrei probabilmente dovuto descrivere il traffico assordante e asfissiante che assedia chiunque nelle chiassose metropoli del nord: Delhi, Jaipur, Agra e le altre. Toyota, Tata, Suzuki, camion, jeep stracariche con gli uomini appesi al cassone, biciclette, motorini con quattro persone a bordo, autobus… E naturalmente gli incidenti stradali.
Bisognava dire della fogna a cielo aperto coi topi per strada che all'alba frugano gli abiti e la pelle dei miserabili che dormono sui marciapiedi della città sacra Varanasi. Parevano morti, non fosse stato per i loro rantoli malfermi e pietosi. Mentre, a pochi metri, i fedeli e i novelli sposi scendono i gaht e sfidano le acque luride pur di immergersi e purificarsi nel sacro Gange assieme alle spoglie di un cadavere bruciato sulla pira. Ma anche la magia che il fiume emana alle prime luci del giorno quando si riempie di foglie di banano che galleggiano trasportando fiammelle votive.
Avrei dovuto raccontare i camerieri del ristorante di Agra, sull'ombreggiata terrazza a due passi dal Taj Mahal. Allontanavano le scimmie dal mio tavolo con la fionda, pensando che mi spaventassero. In realtà ero molto più atterrito da due distinti signori che mangiavano al mio fianco usando la lunghissima unghia del mignolo per attingere agli intingoli.
C'era poi da ritrarre il tassista Shiva che spiega il suo Paese con un sorriso agrodolce: «Qualsiasi cosa succeda, si risolve tutto pagando. L’India è così». Il silenzio rosso mattone della città fantasma Fathepur Sikri e i giovanotti che cercavano refrigerio immergendosi nelle pozze d'acqua. Il palazzo dei venti con le sue mille finestre celanti storie di donne segrete, a Jaipur. O l’architettura dalla solenne aria british giustapposta alle baracche di Mumbay, e la luminosa casa di Gandhi. Ma, sempre a Mumbay, avrei dovuto reimmergermi nel ripugnante odore marcio che emanano gli arti devastati e oscenamente esibiti dai lebbrosi. Lì, stesi come fagotti di stracci, sperano in una moneta sulla passerella verso la moschea Haji Alì. La lebbra in occidente sembra solo reminiscenza dalle parabole evangeliche e invece in India la conosci, ti mozza il fiato e ti sbatte in faccia un progresso che procede a conati. Bisognerebbe dire dei ragazzi che giocano a cricket nei piazzali. Degli uomini che defecano accucciati ai bordi della strada. Oppure delle donne che a mani nude plasmano dei dischi di sterco di vacca: una volta seccati diventeranno tegole o pavimento di casa.
Ci sarebbero da elogiare le grotte-tempio di Ellora e quelle di Ajanta, patrimonio dell’umanità. Dovrei allora dire anche del ristorante Tandoor di Aurangabad, dove i camerieri stanno tutti incollati alla tv ridendo per una specie di telefilm: a veder quel luogo non gli daresti due soldi, invece si mangia un delizioso tahli annaffiato da fresca birra Kingfisher.
E come non ricordare gli alberghi a cinque stelle che ne valgono sette e quelli che invece hanno le lenzuola sporche dal cliente precedente. La bellezza da cartolina del mare di Goa, con l’acqua calda, le palme e il Tantra Shack bar, a forma di palafitte che riparano dal sole giaguaro. Oppure il coloratissimo flea market del mercoledì, ad Anjuna, dove i fricchettoni europei espongono la loro merce mischiandosi ai venditori indiani. Le vacche che percorrono l’autostrada in tutto il Paese e gli elefanti che occupano una corsia intera dalle parti di Amber. E quelli che invece portano sul loro dorso i turisti diretti al Forte giallo ocra.
Ci sarebbe da dire dei treni gremiti, dove gli uomini gridano e alcuni bigliettai, pur di non fare un tubo, si fanno rimpiazzare da dei mascalzoni che però chiedono ai viaggiatori oboli non previsti; e della coppia di anziani turisti francesi che ha provato a protestare, ricevendo in cambio ruvide minacce. Del forte di Gwalior che domina la città con gli inserti blu a rompere la tinta ambrata. Della festa di Utran, quando i bambini fanno la felicità dei venditori di aquiloni e il cielo si riempie di fettucce svolazzanti. Della sacra Pushkar dai mille templi, dove le donne camminano nei loro sari sgargianti e allegri ma è impensabile trovare una birra. Di quasi tutti i musei dove il biglietto per i turisti è venticinque volte più caro rispetto a quello per gli indiani.
Ci sarebbe da raccontare tutto ciò, e probabilmente molto, moltissimo altro. Invece ho preferito parlare della canzone di Jorge Ben. Che rievoca, con un misto di malinconia e allegria – tipicamente brasiliani – quella storia d'amore indiana. Anzi, dice testuale, “la più bella storia d'amore che mi abbiano raccontato”. Perché da lì, dalla storia che ha fatto nascere quel monumento, forse può tornare la spinta a rifare qualche cosa di meraviglioso, come è il Taj Mahal.
Oggi, viceversa, il quotidiano della maggior parte degli abitanti indiani si chiama slum. Possibile che una volta sapevamo costruire cose così belle mentre oggi il vero lusso in India è avere il bagno in una abitazione?, si chiede l’indoamericano Suketu Mehta nel suo libro-reportage ‘Maximum City’. Solo il 40% delle abitazioni ha l'acqua potabile, più di 400 milioni di persone vive sotto la soglia di povertà, quasi altrettanti sono analfabeti e i giornali sono inondati di terribili storie di stupri, racket, vendette, miseria. Ma questa è una storia diversa da quella della ‘potenza economica emergente’.
maurilio barozzi
2013
L’ARTICOLO
-
Scritto tra Dehli, Agra, Varanasi, Mumbay, Aurangabad e Goa, nel 2013.
-